 Il teologo Paolo Benanti parla del Sinodo sull’Amazzonia previsto dal 6 al 27 ottobre: “La biodiversità e la varietà genetica offrono risposte alla crisi climatica e alla fame”
Il teologo Paolo Benanti parla del Sinodo sull’Amazzonia previsto dal 6 al 27 ottobre: “La biodiversità e la varietà genetica offrono risposte alla crisi climatica e alla fame”
Il picco di incendi in Amazzonia che ha seguito l’elezione di Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media sull’attacco che sta subendo la più importante foresta pluviale del pianeta. È un allarme che corrisponde alla portata del rischio: si profila una catastrofe ambientale globale, un’accelerazione drammatica della crisi climatica. Guardare a questo disastro in una chiave esclusivamente ambientale sarebbe però un errore culturale che finirebbe per moltiplicare il danno. Quei roghi di alberi somigliano a quelli dei libri bruciati in Fahrenheit 451 non solo perché è una biblioteca di conoscenze che va in fumo, ma anche perché assieme alla foresta arretrano i diritti civili, l’omofobia diventa sempre più aggressiva arrivando alla censura di testi durante le fiere, i leader scomodi vengono eliminati fisicamente.
C’è un nesso evidente tra la pressione delle ruspe che si fanno strada tra le ceneri di alberi secolari e le stragi degli indios che abitavano tra quegli alberi. Ma c’è un altro nesso meno evidente che sostiene il primo: quello tra i risultati straordinari ottenuti dal mondo occidentale e l’idea di una superiorità a 360 gradi della cultura che li ha espressi. Se non si apre un dibattito su quest’ultima equivalenza, se non si indaga il terreno scomodo di affermazioni da cui non è così facile prendere le distanze, si rischia di lasciare campo libero ai sicari armati dai fazendeiros, i latifondisti che in nome del progresso convertono la foresta pluviale in soia geneticamente modificata. Opporsi alla barbarie dell’assalto ai nativi è certamente un dovere etico, ma conviene chiedersi: quei popoli custodiscono la conoscenza di un diverso rapporto con il mondo di cui sarebbe pericoloso fare a meno?
Continua a leggere su cambialaterra.it








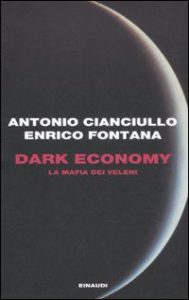


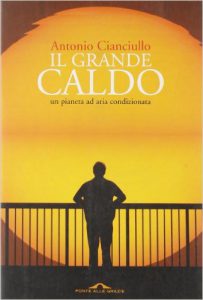







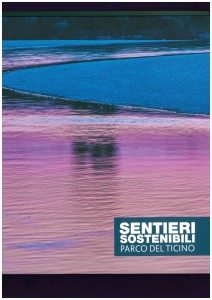 Sentieri sostenibili: il parco del Ticino (2016)
Sentieri sostenibili: il parco del Ticino (2016)